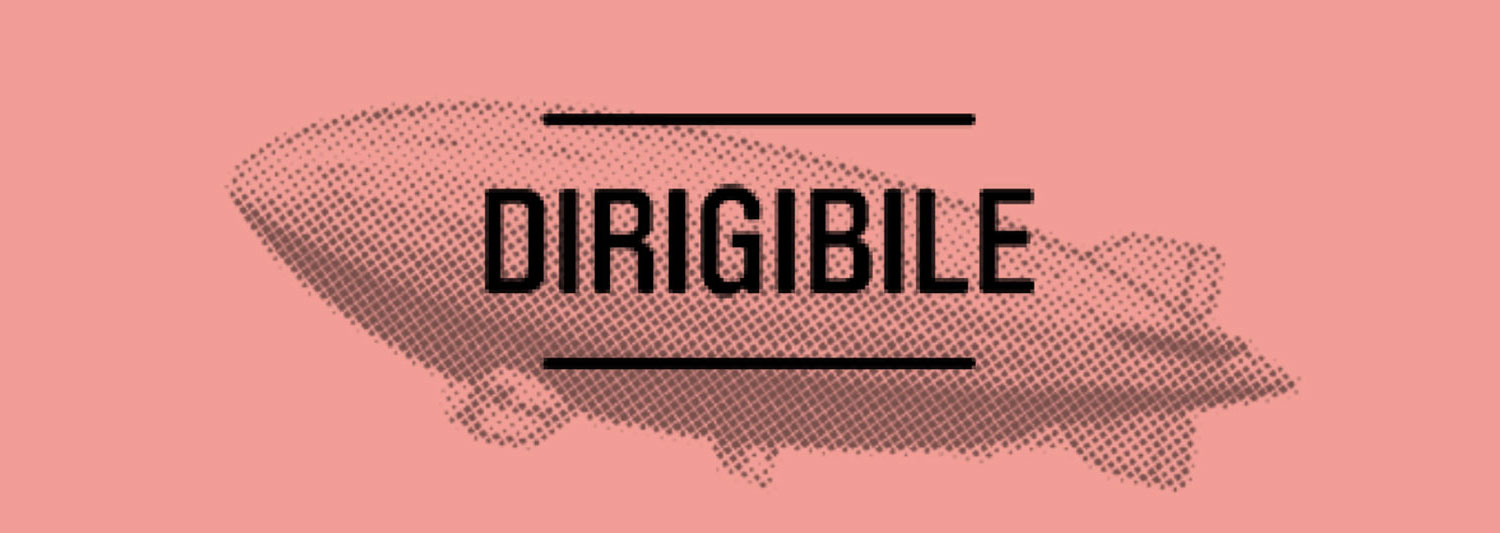Lei oggi coordina il Forum Disuguaglianze e Diversità. Di fatto, di cosa si occupa?
«Faccio il cittadino attivo, uso l’espressione del mio amico Giovanni Moro, metto le mie competenze da economista e da manager in una rete di organizzazioni di cittadinanza e di ricerca. In passato ho diretto un dipartimento del ministero dell’Economia di circa 500 persone».
Alla base del suo pensiero e delle sue politiche, c’è da sempre, e oggi ancor più, una società più giusta. Come stiamo a ingiustizie oggi?
«Stavamo messi male a dicembre 2019, stiamo ancora peggio oggi. Questo è inevitabile perché ogni shock violento, ci dicono le ricerche e la storia, peggiora le faglie esistenti. Era invece evitabile che quelle faglie esistessero. Si sono aperte nell’ultimo quarantennio e riguardano non solo le disuguaglianze economiche note – le differenze di ricchezza cresciute in maniera straordinaria nell’ultimo venticinquennio – ma anche l’accesso ai servizi fondamentali e, importante, il riconoscimento del ruolo delle persone. Ci sono fasce sociali – insegnanti, abitanti delle aree rurali, lavoratori invisibili – di cui non è riconosciuto il ruolo nella società. Queste sono disuguaglianze altrettanto gravi quanto quelle economiche».
Stiamo parlando di sostenibilità ambientale, economica e sociale a 360°, come le coniughiamo?
«Giustizia ambientale e sociale sono parte dello stesso concetto che l’economista Amartya Sen definisce “libertà sostanziale sostenibile”. Un concetto che corrisponde al pieno sviluppo della persona umana a cui fa riferimento l’art. 3 della Costituzione. Questo concetto supera il supposto diaframma fra giovani e anziani e ci guida nella strada di provvedimenti, misure e politiche che possano al tempo stesso migliorare entrambe le due giustizie, ambientale e sociale».
Lei ha recentemente affermato che se si impedisce al capitalismo di schiacciare le condizioni di lavoro e si ottiene una partecipazione strategica tra lavoro e capitale, questo dà il meglio di sé: aumenta la produttività e fa l’interesse generale. Quindi lei crede nel capitalismo?
«Questa espressione è del grande liberal-socialista Paolo Sylos Labini. Credere nel capitalismo non vuol dire pensare che sia l’unico modo di organizzare la produzione, ma prendere atto che è “il modo” di organizzazione della produzione oggi esistente, che esso può essere usato male o bene, come tutti i modi di organizzazione della produzione. Io credo che noi abbiamo usato male, assai male, il capitalismo negli ultimi quarant’anni, trattandolo come un fine e non come strumento. Abbiamo usato male la sua capacità di scatenare gli animal spirits e le capacità imprenditoriali creative che sono la sua forza. Abbiamo anche usato male la sua flessibilità, perché la forza vera del capitalismo è di essere enormemente flessibile: era capitalismo quello della Gran Bretagna dove morivano donne e bambini quando non servivano più ed è capitalismo quello di oggi, in cui siamo sensibili alla giustizia delle persone. Tutto questo vuol dire che se le persone e i lavoratori hanno voce, gli imprenditori saranno indotti a fare più innovazione e usare la loro creatività – Marx direbbe a sfruttare se stessi – non per sfruttare il lavoro, ma per inventare cose nuove».
Nel suo libro Un futuro più giusto lei dice che il Covid-19 ha ampliato le disuguaglianze, ma ci ha mostrato chiaramente e in pochissimo tempo come ripartire…
«Nel libro del ForumDD, curato da Patrizia Luongo e da me, ricordiamo che l’emergenza ha fatto due cose. La prima è ovvia, ma va governata: ha accelerato la trasformazione digitale, che non è in sé né buona né cattiva; sta a noi raccogliere in modo giusto questa palla. L’altra grande novità è più profonda e importante per il capitalismo: ha giocato con le nostre preferenze, con i nostri comportamenti, e li ha spinti maggiormente verso la cura di noi stessi e delle persone, verso cibi di qualità e non a distanza, verso l’autoproduzione di energia e verso, questo è molto importante, una vita che si svolga anche in aree rarefatte e non troppo dense. Di fatto ha modificato le nostre sensibilità. Tutto ciò per il capitalismo rappresenta una nuova domanda. E la cosa più affascinante di questa fase – che possiamo cogliere girando l’Italia, come si deve fare e come ancora faccio – è vedere come alcune persone, lavoratori e imprenditori, la cui prospettiva di vita è stata scardinata, stiano ripensando al loro itinerario con la straordinaria cosa che è la creatività italiana. Questo riguarda non solo i ristoratori e gli albergatori ma anche pezzi del sistema produttivo, manifatturiero e del sistema di cura. Un fenomeno estremamente interessante e rigenerativo, perché se l’assecondiamo produciamo buoni lavori e miglioriamo anche la qualità della nostra vita, facciamo un’operazione dal lato della domanda e dell’offerta».
Veniamo a un aspetto cruciale per il futuro: viene prima la crescita o la chiusura della forbice delle disuguaglianze?
«Chiudere le disuguaglianze ambientali e sociali è la molla dello sviluppo e dell’aumento della produttività. A lungo abbiamo pensato il contrario. Ma una delle caratteristiche dell’essere umano è apprendere dall’esperienza e se per tanto tempo mi dici “non ti preoccupare, cresci, cresci, cresci, poi la crescita arriverà a tutti” ma questa non arriva, anzi, diventa ancora più divisiva, forse è il caso di capire che il nesso causale è esattamente opposto».

Fondazione Prioritalia parte anche dalla richiesta dei manager di avere cittadini e persone competenti e capaci di portare valore e valori in azienda e nella società. Come vede questa opportunità?
«Penso che questo giusto impegno sociale dei manager sia un’opportunità sul fronte interno ed esterno. Interno perché il manager che ha queste sensibilità ottiene il risultato di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, e anche quella che un tempo si chiamava job satisfaction, e al contempo si ritrova pure con un’azienda più produttiva. Determinante è anche l’effetto sul fronte esterno, perché l’azienda non è una monade, l’azienda vive in un territorio e se tu hai manager con queste sensibilità, oltre a contribuire economicamente con investimenti aziendali allo sviluppo del territorio, sentiranno il bisogno di impegnarsi in quella che ritengo sia la chiave del nuovo modo di governare i territori. Sviluppare luoghi e modi di confronto dove lo Stato, che non è onnisciente, dialoga con gli imprenditori, con i manager, con i lavoratori e con i cittadini per capire come espandere la città, come disegnare la mobilità… E c’è di più, il manager che spende un pizzico del proprio tempo fuori dalle mura aziendali porta fuori la cultura imprenditoriale e manageriale, che è un pezzo del Paese».
Quali sono alcuni dei fattori portanti del Rapporto “15 proposte per la giustizia sociale”?
«Tra i principali ci sono: fare sistema, democratizzare la conoscenza, combinare in modo innovativo pubblico, privato e sociale. Sono gli ingredienti di una possibile nuova fase del rapporto fra capitalismo e democrazia. Spostano l’obiettivo di un’impresa dalla sola massimizzazione del valore per gli azionisti all’essere luogo e punto di incontro di stakeholder diversi. Al tempo stesso, sul fronte dello Stato, vuol dire superare quella visione antica, che è purtroppo uno degli elementi di continuità, iper-illuminista fra socialdemocrazia e neoliberismo, di un’amministrazione presuntuosa che pensa di sapere tutto, di poter disegnare regole e procedure uguali per tutti, indipendentemente dai contesti, invece di essere un attivatore di processi, visto che una gran parte dei saperi è nella società, nel lavoro e nell’impresa. Solo così facendo possiamo arrivare a quel nuovo equilibrio che andiamo tutti cercando, gestendo lo straripamento del capitalismo e la crisi della democrazia».
Una delle sue proposte cardine è indirizzare l’accelerazione della trasformazione digitale verso la diffusione della conoscenza e la creazione di buoni lavori. Perché e come?
«Ci sono due scenari. Uno è proseguire con alcuni grandi monopoli digitali globali che attraverso le piattaforme possedute spiazzano le altre imprese, portando risultati attraenti per i consumatori, ma nel lungo termine riducendo il grado di concorrenza del capitalismo, la diffusione della conoscenza e, anche, standardizzando le organizzazioni e addirittura le città. L’altro scenario è quello delle piattaforme digitali statalizzate, come in Cina, usate per stabilire e distribuire crediti sociali, per definire quali siano i criteri in base a cui punire i cittadini. Noi possiamo costruire una terza strada, dove le piattaforme collettive siano sfruttate come luogo di diffusione della conoscenza. In concreto, parlando di mobilità, se, come sta tentando di fare Barcellona e con primi tentativi Bologna, io costruisco una piattaforma digitale pubblica che raccoglie tutti i dati sulla mobilità, accessibile a tutti, allora un gruppo di ragazzi e ragazze potrà utilizzare quei dati e proporre alla cittadinanza una soluzione della mobilità migliore di quella esistente. Avrò così scatenato la parte migliore del digitale, perché avrò diffuso l’informazione e aumentato l’innovazione e la concorrenza del mercato».
E come diffondere questa innovazione?
«Per esempio, citando una proposta che abbiamo fatto recentemente, mettendo a valore la rete delle imprese pubbliche italiane, la spina dorsale del nostro sistema produttivo, come ha ricordato il giorno della presentazione Sergio Dompé. Quelle imprese pubbliche hanno una capacità di ricerca assai elevata e sono all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Penso a Leonardo, Ferrovie Italiane e Poste, che in modi e dimensioni diversi possono essere i gangli costitutivi per costruire piattaforme digitali collettive e innovative per il disegno dei servizi fondamentali. Questa è una carta che il Paese può giocare anche utilizzando i fondi europei che arriveranno adesso. Andare nelle aree interne e sentirsi dire dalle famiglie e dai lavoratori che gli orari degli autobus e delle coincidenze sono sbagliati, dagli imprenditori che sono costretti a cambiare gli orari perché non c’è un sistema di mobilità e poi sentirsi dire dalla società che ha vinto i bandi che loro sarebbero in grado di fare di meglio ma non è ciò che il bando gli ha chiesto. Questo non può succedere. Ti fa capire che prima ancora di aumentare i fondi bisogna usarli bene. E in questo senso l’impresa pubblica diventa portante. Spesso nell’impresa pubblica c’è un potenziale tecnologico e un management molto interessante. Già nel passato l’impresa pubblica ha svolto una funzione di driver. Noi non chiediamo – si badi bene – che la politica torni a usare quelle imprese per obiettivi di breve termine, ma che ci siano delle missioni strategiche di sviluppo tecnologico e settoriale che solo lo Stato può sostenere come azionista paziente. Che poi non è tanto diverso, come ottica, da ciò che avviene in quelle imprese private dove gli investitori non guardano ai risultati di breve termine ma a quelli di lungo periodo».

Altri fattori portanti dello sviluppo sostenibile che lei auspica, disegna e immagina sono le università. Come e perché?
«Ci sono in Italia esperienze di rapporti fra università e pmi che sono una delle importanti ricadute sociali indispensabili in un Paese che ha moltissime pmi e dove questa è stata spiazzata dall’evoluzione della conoscenza, della tecnologia e della competizione degli ultimi tre decenni. Perché da tempo la conoscenza non è più incorporata nelle macchine, ma è immateriale. La pmi degli anni 70 si comprava la macchina a controllo numerico e la conoscenza, oggi non è più così. Quella conoscenza costa molto e le pmi non investono e quindi si impoveriscono e hanno fragilità, bassa produttività: è questo che le mette gravemente a repentaglio sotto l’incalzare della crisi. Non credo che dobbiamo puntare su una grande Agenzia nazionale per la diffusione della tecnologia come la Germania, perché da noi potrebbe diventare il solito carrozzone. Dobbiamo piuttosto far crescere i rapporti, il dialogo e le sinergie tra università e pmi su tutti i territori. Valutare le esperienze che già esistono e migliorarle. Un modo per aiutare anche il superamento di un altro gap delle nostre pmi rispetto a quelle dei nostri principali competitor. La vera debolezza delle pmi non è infatti la dimensione, ma piuttosto lo scarso ricorso anche a manager esterni alla famiglia dell’imprenditore (lo fanno il 30% da noi e il 70% in Germania). Un rapporto con le università può accrescere la consapevolezza di un ricambio di management non forzato ma graduale, che noi indichiamo come determinante nella nostra proposta».
L’obiettivo è anche quello di riportare sui sentieri dell’innovazione e dello sviluppo i territori, oggi troppo spesso marginalizzati. Quale ruolo hanno nel suo disegno?
«Anche a seguito del lockdown, abbiamo sviluppato ulteriormente quanto era già stato proposto nel ForumDD: una politica moderna di sviluppo che serva a usare bene i fondi e alle città per fare un salto. Non abbiamo certo solo Milano. Ci sono altre città di grande rilievo, la prima di tutte è Napoli. Oggi Milano si è rimessa a ragionare sulla mobilità: certo, sappiamo che non torneranno tutti quanti a lavorare negli uffici. Sappiamo che è avvenuto un cambiamento permanente. Di fronte a questo, ad esempio, la Regione Lazio sta modificando l’organizzazione del lavoro e dell’uso dei propri edifici, migliorandone l’accesso ai rappresentanti delle Province, dei Comuni, degli amministratori. Tutto questo accade perché abbiamo intravisto modi diversi dell’organizzazione della produzione del settore terziario. Questa trasformazione richiede un’autonomia di decisione dei comuni che secondo la nostra proposta si deve combinare con forti indirizzi nazionali settoriali, cioè né top-down – per riassumere con uno slogan – né bottom-up, ma forti indirizzi nazionali sulla casa, sulla mobilità, sugli spazi collettivi. Ma il disegno, la caduta a terra, va attuata con un forte ruolo dei Comuni, che sono poi la parte dove c’è la classe dirigente più interessante del Paese. Questo è il nocciolo della nostra proposta fatta al governo. Speriamo che ci ascolti nella programmazione di settembre/ottobre. Il mio timore è che ripartano i bandi a livello nazionale e che decidano dall’alto come devono essere fatte le cose. E così alla fine vincono le consulenze decontestualizzate e la strategia sfugge alle città, alla città democratica».
Forse il cuore di tutta la sua rivoluzione sta nell’assicurare dignità e partecipazione strategica al lavoro. Come fare e che ruolo hanno in questo i manager?
«Noi non siamo particolarmente rivoluzionari nell’obiettivo, ma innovativi nella proposta. Visto che Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, non più tardi della primavera del 2018 dicevano che ci vuole partecipazione strategica del lavoro, puntavano alla consapevolezza che il lavoro va coinvolto. Quindi l’obiettivo non è rivoluzionario ma l’innovazione è che noi diciamo “Bene. Fatelo!”. Perché fino ad ora, con altrettanta chiarezza, nessuno dei promotori si è mosso in questa direzione. Noi diciamo che ci sono tanti modi in cui realizzarla, alcuni la chiamano “cogestione”, io parlerei più correttamente di partecipazione strategica. Noi pensiamo che dei vari strumenti che abbiamo visto in opera in Europa, quello olandese – un organo che si affianca e non si mescola con il cda – sia il più interessante, ma vada reso più moderno. Da qui nasce la proposta del consiglio del lavoro e della cittadinanza».
Cioè?
«Sono tre le novità. Primo, che in quel consiglio si ricomponga tutto il lavoro, cioè non solo lavoratori protetti ma anche non protetti, che è una cosa che il sindacato dovrebbe avere a cuore, visto che non riesce a rappresentare i non protetti, in modo tale che sentiamo l’opinione dell’intera filiera. Secondo, che ci sia una rappresentanza dei cittadini con interessi ambientali. Il vantaggio è di non ascoltarne le grida solo quando cascano i fumi o le polveri, ma di dare loro voce ben prima, così sarà possibile realizzare investimenti che evitino quelle polveri. Il terzo vantaggio è l’innalzamento del confronto tecnico fra le parti. Il confronto, o conflitto, quando è informato è un bene perché chi confligge deve farsi carico di dire perché esprime un giudizio negativo e qual è l’opzione alternativa che propone. Noi pensiamo che se nascessero dei consigli del lavoro e della cittadinanza avremmo il triplice effetto di consentire/costringere il lavoro, i rappresentanti degli ambientalisti e anche il management ad alzare la qualità del confronto e quindi è una sfida anche per il management familiare, perché mi ritrovo davanti un interlocutore che mi mette in discussione l’investimento che sto facendo e quindi viene voglia a te, famiglia, di affidarti un po’ di più al manager. Quindi io la vedo come un’occasione d’innalzamento della qualità del confronto nei territori. Per essere chiari, a regime potrebbe essere anche una norma nazionale, ma poiché noi siamo degli sperimentatori di spirito e poiché è evidente che è uno strumento innovativo, noi diciamo agli imprenditori, ai manager che ci credono, ai sindacati “proviamone quattro, sperimentiamoli”, in modo tale che poi quando decideremo di raccomandarli a tutto il Paese avremo capito cosa fare e cosa non fare».

Un ruolo chiave ha anche la macchina pubblica. Pensa a una “macchina pubblica ibrida” ed ecocompatibile, cioè capace di favorire un adeguato ecosistema, e come?
«Sì, “macchina pubblica ibrida”, mi piace e gliela rubo. È lo sperimentalismo democratico, cioè io Stato sono consapevole di dover interpretare il mandato che mi viene conferito dalla politica e dai cittadini e quindi devo prendere delle decisioni, ma sono anche consapevole della mia terribile ignoranza. So che i saperi sono annidati nelle università, nelle imprese, nelle organizzazioni del lavoro e di cittadinanza e devo fare in modo di ascoltarli in maniera sistematica. In questo mondo, dove i saperi sono diffusi, sia centrali che locali, ognuno deve poter mettere il naso nella costruzione degli altri. Io faccio in modo che le parti contribuiscano quando faccio le strategie e le lascio attuare dalle mie articolazioni territoriali, cioè dai Comuni, in una maniera ancora fortemente partecipata. Il problema è che noi nello Stato non assumiamo le persone sulla base delle competenze organizzative, ma solo delle competenze disciplinari e quindi spesso ci ritroviamo con persone magari molto competenti ma non utili allo scopo. Abbiamo una grande opportunità perché sta uscendo la generazione che è entrata negli anni 70. Abbiamo una chance di svecchiamento che non ci costa niente perché il rimpiazzo è già stato deciso ed è a bilancio. Quindi il Forum nonpropone di spendere di più di quanto previsto. Ma queste 600mila persone da inserire nella pubblica amministrazione le vogliamo assumere bene? Vogliamo valutarle per le competenze organizzative e soprattutto accompagnarne l’entrata come fanno le aziende private? Quando le immettiamo ne vogliamo curare l’inserimento per non abbandonarle nelle mani dei più cinici, per cui dopo due anni i più capaci se ne vanno via e i meno coraggiosi si atrofizzano perché hanno già tirato i remi in barca?».
Quale deve diventare ed essere il ruolo dei manager pubblici? E deve esserci più osmosi con quelli privati?
«La parola manager pubblici va subito declinata in due tipologie. Una è quella dell’amministratore delegato o del dirigente di un’impresa pubblica di cui abbiamo parlato prima, l’altra è quella del manager della pubblica amministrazione. Il manager pubblico di aziende sul mercato, e quindi delle imprese pubbliche italiane, ha già un forte ricambio con il privato. Piuttosto, come abbiamo detto, è una risorsa che non usiamo abbastanza. Il management della PA, invece, non ha tanto bisogno di ricambio con il privato, ma piuttosto di una forte contaminazione con esso. Questo è ciò che manca, che si dovrebbe fare nella formazione, lavorando insieme, costruendo momenti di contatto. Momenti di contaminazione in tutte e due le direzioni, perché consentirebbe anche una maggiore fiducia del management che lavora nel sistema privato nei confronti di quello che lavora nella PA. Questo sì lo vedrei in modo molto positivo ed è ciò che noi raccomandiamo».
Lei parla anche di favorire un ricambio manageriale indispensabile per molte pmi. Fa forse riferimento alle troppe imprese familiari ancora oggi in Italia, a differenza di quelle più competitive, ancorate a un management solo familiare?
«Sì, con la precisazione che a me non dispiace l’impresa familiare nel senso di proprietà. Lo dico con tutta sincerità, questo è un asset che anche i tedeschi hanno, ma hanno anche manager esterni e la famiglia capisce che deve fare un passo indietro e ritagliarsi un ruolo di indirizzo e di missione anche nel territorio, perché spesso la famiglia è legata al territorio ed è una componente importante in Italia».
Quali manager servono per uno sviluppo più giusto, sostenibile?
«Servono figure che abbiano insieme una cassetta degli attrezzi – io ci credo alla tecnica – ma serve anche l’umanesimo, cioè avere capito la storia, la geografia e la filosofia. Quando parliamo di giustizia sociale, territorio, comunità, principi della Costituzione, li devi sentire e li senti se nella tua formazione c’è un pezzo di tutto questo. Poi sta a te combinare i tuoi ingredienti. Io ho la sensazione a volte che manchi solo la seconda, che si scivoli su questo. Hai delle buone intenzioni però non hai valore aggiunto. Parliamoci chiaro, un manager deve soprattutto prendere delle decisioni, se hai solo la prima e ti manca la seconda, tu percepisci il sociale in modo compassionevole e quindi non sei di aiuto. Ritorniamo anche ai lavoratori. La competenza orizzontale generale non riguarda solo il management ma riguarda anche loro. L’altro giorno parlavo con un importante imprenditore che mi raccontava che “in una parte delle ore noi facciamo musica, discutiamo delle tematiche ambientali ecc. perché in questo modo tieni i dipendenti all’erta e attenti ai cambiamenti del mondo”. E, aggiungo io, così saranno più pronti ad affrontare gli shock».
Quale ruolo per le diversità, donne, giovani ecc. e per l’intergenerazionalità?
«Ci sono due sensi in cui noi abbiamo voluto usare la parola diversità. In primo luogo facciamo riferimento al fatto che esistono diversità sistematiche di genere ed etniche che richiedono di essere affrontate. Mi riferisco alla subalternità di genere. L’Italia è ancora gravata da forme patriarcali che riemergono in maniera pesante e che privano l’intera società del contributo pieno delle donne. È evidente che per affrontare questa subalternità non devo realizzare interventi uguali per tutti, devo pensare a come fare emergere la prospettiva di genere. Questo vale anche per la subalternità etnica. Se io voglio che la comunità albanese, che è un pezzo fondamentale della filiera del latte, contribuisca a rigenerare culturalmente e produttivamente il nostro Paese, se voglio assicurare anche a loro la giustizia sociale di cui andiamo parlando, devo tener conto della loro diversità con strumenti adatti alla loro condizione. La seconda accezione della parola diversità si riferisce a ogni singola persona, come nell’art. 3 della Costituzione, che è il punto di riferimento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Essere uguali vuol dire dare a ognuno la chance di esprimere la propria personale diversità. Questo dice la Costituzione, che è uno straordinario incontro del pensiero liberale, socialista e cristiano sociale».

Quale politica e politiche servono per costruire un futuro di sviluppo e più giusto?
«Attuare pienamente la nostra Costituzione e tornare ad avere dei partiti che non solo siano responsabili, ma rappresentino e si prodighino ad ascoltare e rappresentare. Il concetto di Bauman di “società liquida” è stato utilizzato come un alibi da tutta la classe politica, è diventato la scusa per dire che, essendo la società liquida, noi non possiamo più rappresentarla. E quindi, a seguire, che c’è un solo modo di governare e non c’è alternativa. Questo lo hanno detto tutti da sinistra a destra, tutti insieme, riducendo la politica a tecnica. Io lo trovo terribile perché la democrazia è fondata su due assunti. La prima è la sovranità popolare che, fino a prova contraria, poiché non si può esprimere né attraverso una grande agorà né attraverso un dittatore, richiede la costruzione della rappresentanza. La seconda è il dibattito pubblico, un momento dove tu dai l’occasione – come non importa, ogni fase della storia ha i suoi modi – alle persone di influenzare con i propri saperi le decisioni dei propri rappresentanti. Io penso che i partiti – poi li chiamino movimenti, li chiamino come vogliono – abbiano oggi un ruolo fondamentale. Certo, non saranno più i partiti di massa che potevano pensare di incorporare tutti i saperi. Adesso larga parte dei saperi è e resterà fuori dai partiti, nelle organizzazioni di cittadinanza, del lavoro, dell’impresa. E allora i partiti devono diventare interessanti per queste organizzazioni, devono far venire voglia a queste organizzazioni di parlare con loro per travasare i loro saperi, per influenzarli. Non è quello che oggi avviene».
E le politiche?
«Le politiche le abbiamo dette prima, ma riassumerle non è male. Noi diciamo in primo luogo: accesso ai saperi perché nei momenti difficili della storia servono i saperi dei grandi centri quali università, imprese pubbliche e scuola, sia quelli dispersi nei territori da mettere e rimettere in gioco. Le politiche di sviluppo vanno fatte così, attingendo a entrambi quei saperi. E poi, bisogna riequilibrare i poteri a favore del lavoro. E trasferire potere ai giovani. La crisi generazionale è un dato specifico dell’Italia. Abbiamo un numero enorme di persone che non studiano né lavorano, dispersione scolastica altissima, un esodo senza rientro. Il problema infatti non è l’esodo. Perché se i giovani vanno fuori ad approvvigionarsi di conoscenza va benissimo, ma il fatto è che poi non tornano. E poi l’esodo dal sud verso il nord, dalle aree interne verso le aree urbane, e alla fine bassa fertilità e caduta demografica. Ecco allora che pesa la nostra proposta di curare l’assunzione di 600mila giovani nella PA. E poi la nostra proposta di eredità universale. Per livellare le opportunità noi proponiamo un trasferimento a tutti i ragazzi e le ragazze al compimento dei 18 anni di 15mila euro. È una cifra che può fare la differenza. Ed è un provvedimento che si può finanziare modificando la tassazione sull’eredità e le donazioni, esentandone tutti quelli che ricevono fino a 500mila euro e rendendola progressiva al di sopra di quella soglia».
In tutto questo, qual è il ruolo delle cosiddette classi dirigenti?
«Quelle del lavoro e dell’impresa possono contare molto in questo momento e devono capire che spetta a loro essere più innovative, fare il passo del cavallo, rischiare collettivamente e non solo individualmente, cioè esprimere un pensiero. Quelle della PA devono aprirsi al rinnovamento. Quelle della politica devono capire che invece di perpetuarsi per riuscire in qualche modo a essere rieletti possono forse avere un’ambizione più grande, di diventare la classe dirigente che ha fatto cambiare passo al Paese, di generare un forte ricambio, di non essere cinici. Di cinici ne abbiamo abbastanza».
E quello dei cittadini in generale?
«Di capire che la rabbia e il risentimento espressi al bar, su Twitter o su Facebook o nel voto non gli cambieranno la vita. Se sono arrabbiati devono certo protestare, tornare a scendere in piazza. Lo dico in modo chiaro. Devono pretendere soluzioni e azioni ai propri rappresentanti, chiunque essi siano. Io ho paura della tensione repressa, del conflitto sociale che non si esprime, per esempio a ottobre/novembre, perché quello che non si esprime produce autoritarismo».
Uno shift come quello ipotizzato quali tempi ha per vedere i primi risultati?
«Qualcosa va fatto subito. Sono orgoglioso di come noi abbiamo presidiato il Covid sul piano sanitario, io credo che la Germania e l’Italia abbiano ben agito dal punto di vista di come hanno parlato al Paese e hanno gestito la salute. Gli errori sono stati fatti dappertutto, ma io mi sento orgoglioso di essere italiano. Vorrei però essere altrettanto orgoglioso di come reagiamo in ambito sociale in cui non vedo la stessa forza e ne abbiamo tanto bisogno proprio a settembre/ottobre. Perché le linee d’indirizzo dell’uso di quei fondi che arriveranno dall’Europa e non solo sono la prima prova dello scatto. Bisogna leggerlo lì il cambio di passo, non sussidi e liste di progetti, ma obiettivi strategici che animino il Paese, che offrano una visione al Paese e tutto questo deve essere sul tavolo a fine ottobre. “Evviva, abbiamo i soldi, ma non basta”. Arrivo persino a dire che se non agiamo al meglio con quei soldi potremmo fare danni».

Fabrizio Barca è il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. È stato dirigente di ricerca in Banca d’Italia, capo dipartimento nel ministero Economia e Finanze, presidente del comitato Ocse per le politiche territoriali, advisor della Commissione europea, ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti. Ha insegnato in università italiane e francesi ed è autore di numerosi saggi e volumi. È stato recentemente tra i protagonisti del webinar “La sostenibilità economica è sociale” organizzato da Prioritalia e Manageritalia. Se sei interessato puoi riguardarlo sul canale Youtube di Manageritalia, sulla pagina Facebook nazionale e su quelle delle Associazioni territoriali.

Un’agenda radicale: intervenire subito perché nessuno resti indietro nella crisi da Covid-19
È urgente imboccare la strada di un futuro più giusto, prendendo di petto il problema dei problemi: le gravi disuguaglianze e il senso di ingiustizia e impotenza che mortificano il Paese. La crisi Covid-19 ha reso ancora più evidente questo stato di cose e ha aperto molteplici scenari. Sviluppando le “15 proposte per la giustizia sociale” elaborate dal Forum Disuguaglianze e Diversità, alleanza originale di cittadinanza attiva e ricerca, il volume fornisce uno schema concettuale per affrontare l’incertezza e soluzioni operative per cambiare rotta. UN FUTURO
PIÙ GIUSTO Rabbia, conflitto e giustizia sociale – A cura di Fabrizio Barca e Patrizia Luongo – Il Mulino