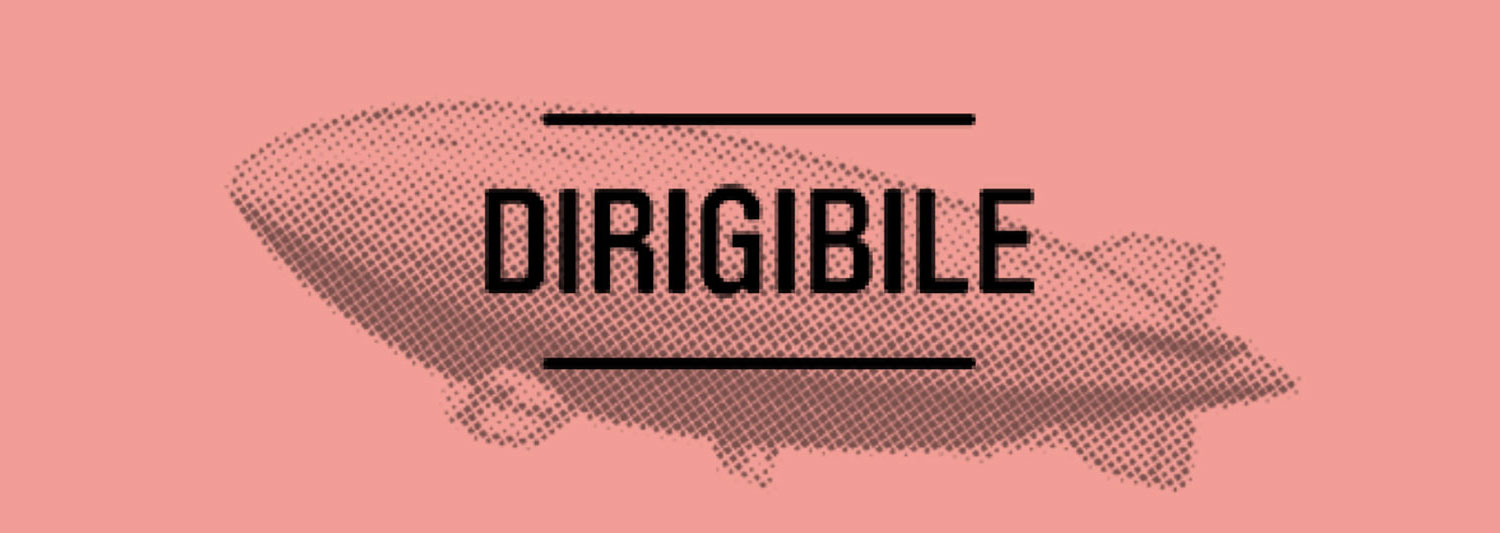La pandemia ha spinto all’estremo il lavoro a distanza e ora resta da capire cosa succederà delle metropoli sino a ieri unico centro di attrazione per aziende e lavoratori e centro di tutto quello che faceva innovazione.
LE METROPOLI AL CENTRO DELLO SVILUPPO
Un fenomeno guidato, come ha ben fotografato Enrico Moretti nel suo libro La nuova geografia del lavoro (2013), dai vantaggi della concentrazione di saperi e scambi di valore in un dato luogo dove si concentravano:
“La chiave sta nel concetto di esternalità del capitale umano: la condivisione del sapere aumenta la produttività (e la produttività genera prosperità). La diffusione del sapere e l’aumento della produttività attraverso l’interazione costante tra gli innovatori non è però l’unica forza di agglomerazione”.
Il professor Moretti ne individua almeno altre due.
Il primo è un mercato del lavoro denso. Il settore hi-tech impiega lavoratori qualificati, dunque con specializzazioni ben precise. Per un lavoratore del genere è più facile trovare un’offerta di lavoro relativa alla sua specializzazione, laddove ci siano concentrate molte imprese del settore, sicché tende ad emigrarvi. Viceversa, la compagnia che cerca un lavoratore altamente specializzato ha più possibilità di trovarlo in un hub hi-tech. La seconda forza di agglomerazione è costituita dai servizi specializzati per questo tipo di aziende, con meccanismi di domanda-offerta non troppo dissimili da quelli del mercato del lavoro specializzato.
SI CAMBIA PARADIGMA?
Certo, non siamo ancora fuori dagli effetti del virus, ma qualcosa sta cambiando proprio in queste grandi aree metropolitane, centro assoluto di tutto quanto era innovazione, valore e profitto sino a ieri. Qui, oggi, migliaia di dipendenti delle aziende tecnologiche e non obbligati o lasciati liberi di scegliere se lavorare da casa e/o in sede hanno deciso per lo smartworking e quindi di lasciare le loro case in affitto per trasferirsi altrove, dove i costi di locazione sono decisamente più bassi. Questo sta accadendo a San Francisco, ma non solo, dove il costo degli affitti è sceso già in pochi mesi del 10-15%.
Il rischio è quello di intere aree metropolitane che perdono abitanti con effetti a catena su tutta l’economia urbana: dalla discesa del prezzo delle case e degli uffici alla riduzione di tutta una serie di servizi che svolgono il ruolo di indotto, dai bar ai ristoranti, trasporti, negozi, ecc. Forse, a conti fatti, non sarebbe un grande affare, come ben vediamo oggi, per restare in Italia, soprattutto, ma non solo, a Milano, dove è vero che mancano i turisti, ma manca anche quell’insieme di vita professionale, culturale e sociale che era il plus incontrastato.

PRODUTTIVITÀ FA RIMA CON SOCIALITÀ
Anche perché verrebbe sicuramente meno quel “quid” che aveva spinto la crescita portentosa delle grandi metropoli, ovvero la concentrazione di valore e lo scambio che avviene proprio con i rapporti spesso fisici tra le persone e con quella vita sociale e culturale che diventa un unicum con quella professionale.
Infatti, proprio a questo proposito, come dice Moretti, l’isolamento, nel lungo periodo, non favorisce la produttività, ma la riduce: “Oggi tutti stanno sostanzialmente lavorando su progetti nati prima del Covid, e dunque si nota l’incremento di produttività. Ma senza il confronto diretto, il dialogo, la presenza, il rapporto dal vivo con i colleghi o con i clienti, difficilmente nasceranno altri progetti: l’isolamento non è mai creativo”.
Dunque, in prospettiva, un mondo del lavoro “solitario” finirebbe con spegnere entusiasmo, creatività e produttività, con danno per le aziende e per i lavoratori, anche per quanto riguarda le carriere. E questo vale anche per chi studia, come dice Tito Boeri: anche in ambito universitario la “solitudine” riduce la possibilità di crearsi quelle reti di rapporti che solo dal “vivo” si possono intrecciare e che sono fondamentali per andare avanti, sia intellettualmente sia da un punto di vista di carriera.
QUALE FUTURO?
Lo scenario meno apocalittico di quello che vede le grandi città svuotarsi potrebbe essere quello dettato da un lavoro che è un misto di ufficio e fuori ufficio (casa, spazi di coworking, ecc.), un vero smartworking che metta nella migliore sinergia le esigenze delle persone, delle aziende, delle città… Questo è quello che anche Moretti ritiene più plausibile: “Non c’è ragione di pensare – osserva – che le forze economiche accettino il declino delle città. Inoltre, appare improbabile che i lavoratori, trasferiti nelle aree rurali, rimangano attivi e creativi nel lungo periodo, rispetto a quelli che vivono nelle grandi città”.
Ragionevolmente, si può quindi presumere che in futuro ogni dipendente lavori uno o due giorni a settimana da casa, e gli altri in ufficio. In questo caso, la riduzione della “presenza” fisica sarebbe, rispettivamente, del 20 e del 40%. Con conseguente riduzione del 20 o del 40% del traffico dovuto agli spostamenti casa-lavoro, ma anche dei metri quadri necessari alle aziende, con equivalente riduzione dei valori immobiliari degli uffici (ma non delle abitazioni).

Le città resterebbero comunque il cuore pulsante del lavoro, ma con notevoli vantaggi in termini di qualità della vita. Pensando anche che, stando a lavorare da casa, alla sera sarebbe più comodo andare in città per vivere, invece per scapparci sempre di corsa nel quotidiano vieni e vai dei commuter, che poi difficilmente li porta a vivere le città in tutte quelli implicazioni che come abbiamo visto sopra sono determinanti per la crescita del sistema e per quella professionale dei singoli.
In questo futuro possibile e auspicabile dovrà anche esserci spazio per una rivalutazione di senso e significato dei territori, anche in rapporto alla metropoli e alla capacità di fare sinergia con queste ed essere così centro e propaggine dell’innovazione, con notevoli vantaggi nel portarla anche dove oggi non c’è. Anche perché questa tendenza a riscoprire i territori e una vita più “sostenibile” sotto ogni punto di vista era già in atto prima del Covid-19, soprattutto tra i Millennials.